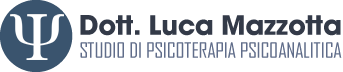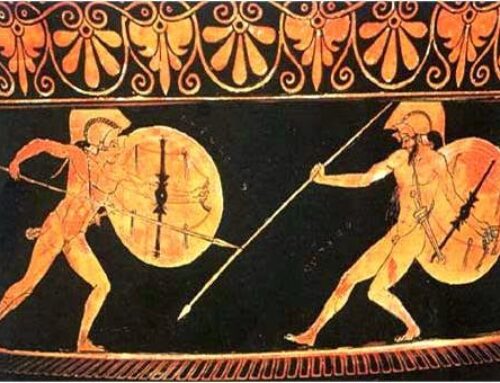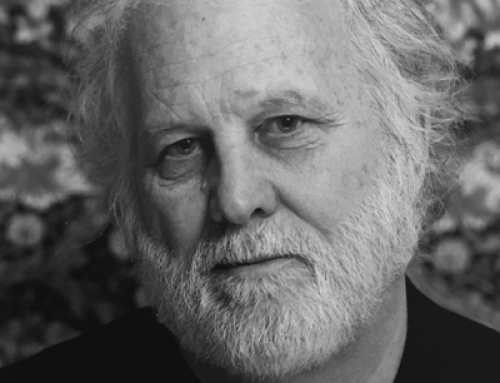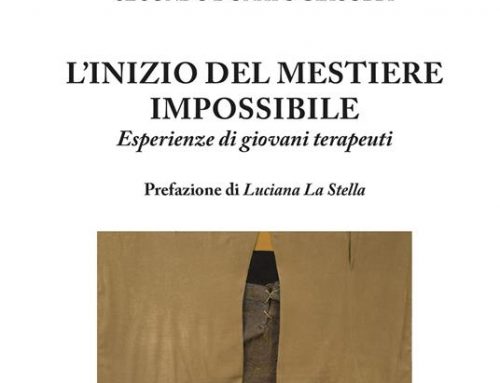Nel 1836 il francese Mare Dax riferì di aver riscontrato un interessante elemento comune in alcuni dei suoi pazienti: nella sua lunga carriera il medico di campagna aveva visitato più di 40 donne e uomini con difficoltà di linguaggio causate da lesioni cerebrali ed il fatto curioso era che a tutti Dax aveva diagnosticato una lesione all’emisfero cerebrale sinistro. Il medico francese sostenne quindi la tesi che quell’emisfero dovesse svolgere diverse funzioni e che sovrintendesse proprio alla capacità del linguaggio. In un primo momento il suo intervento suscitò poco interesse, ma presto si moltiplicarono i riferimenti al rapporto di asimmetria funzionale tra i due emisferi, semplicemente sulla base delle osservazioni condotte sul comportamento di pazienti cerebrolesi. Divenne così sempre più evidente che la funzione del linguaggio peggiorava notevolmente in seguito a una lesione al lobo sinistro del cervello. I pazienti con lesioni a livello dell’emisfero destro, invece, accusavano molto più spesso disturbi di percezione o di attenzione. Un particolare gruppo di questi soggetti con danni all’emisfero destro tralasciava tutto ciò che si trovava nella parte sinistra del campo visivo. Non toccavano il cibo che occupava il lato sinistro del piatto e si pettinavano soltanto i capelli a destra: una patologia che gli studiosi oggi chiamano neglect, o eminegligenza spaziale unilaterale. Ulteriori passi verso la comprensione delle funzioni dei due emisferi cerebrali furono compiuti negli anni Sessanta dai neurologi con la cosiddetta chirurgia split-brain, sviluppata specificamente come terapia dei malati di epilessia. In questo tipo di intervento i medici troncano i fasci di fibre nervose che collegano i due emisferi, impedendo così la diffusione di stimoli fuori dal loro controllo. Il troncamento interrompe anche tutte le comunicazioni tra gli emisferi e dà agli studiosi del cervello la possibilità di esaminare le potenzialità di entrambi presi singolarmente.
I risultati di queste ricerche hanno indicato che le due parti del cervello percepiscono, apprendono e ricordano in maniera indipendente l’una dall’altra. Gli emisferi hanno però diversi metodi e diverse capacità di elaborazione. Se di volta in volta a pazienti sottoposti a split-brain si forniscono informazioni di natura visiva, uditiva o sensoriale per i singoli emisferi, si nota che la parte sinistra ha una particolare abilità nei processi analitici e nella rielaborazione del linguaggio. Inoltre, in questo emisfero le informazioni sono elaborate prevalentemente una dopo l’altra, in modo sequenziale. L’emisfero destro, invece, eccelle nelle funzioni spaziali e nelle capacità musicali, e preferisce interpretare gli stimoli come un unico insieme, in modo parallelo.
In poco tempo si è compreso che queste differenze sono praticamente insignificanti per gli individui sani. In linea di principio, ogni informazione che arriva da un lato resta a disposizione anche dell’altro per mezzo delle connessioni che mettono in comunicazione le due parti del cervello. E proprio in relazione a funzioni più elaborate, come per esempio i processi di apprendimento, oggi i ricercatori ritengono che entrambi gli emisferi cerebrali svolgano le proprie funzioni come se si tenessero per mano. Tuttavia, c’è una particolare capacità dell’uomo che distingue non soltanto il cervello sinistro dal destro ma anche i destrimani dai mancini: parliamo della capacità di esprimersi verbalmente. Una prima analisi dell’organizzazione funzionale della lingua fu quella compiuta nel 1949 dal neurologo Juhn Wada, mediante il test che oggi porta il suo nome. Per mezzo di un anestetico iniettato in una della due carotidi, destra o sinistra, lo studioso giapponese riuscì a disattivare temporaneamente di volta in volta un emisfero anche negli individui sani, rendendo possibile un’osservazione più attenta e precisa dell’emisfero opposto.
Sfruttando questa tecnica, nel 1977 Brenda Milner e Theodore Rasmussen del Montreal Neurological lnstitute pubblicarono uno dei più completi studi sul tema, confermando quello che già 150 anni prima il medico condotto Dax aveva intuito: nel 98% dei destrimani il linguaggio viene elaborato prevalentemente nell’emisfero cerebrale sinistro. Nel caso dei mancini, invece, la situazione non è altrettanto chiara: in due terzi di essi, come per i destrimani, l’emisfero sinistro gestisce la maggior parte delle funzioni linguistiche; negli altri domina l’emisfero destro oppure entrambi collaborano in egual misura, controllando ognuno determinate funzioni. È quindi evidente che il mancinismo non rappresenta semplicemente il rovesciamento del destrimanismo. E inoltre lateralità e linguaggio non sembrano essere necessariamente in relazione.
Per alcuni scienziati il motivo della frequente dominanza dell’emisfero sinistro nel linguaggio è legato al fatto che gli organi implicati, come la laringe e la lingua, non sono altro che strutture poste sull’asse di simmetria del corpo umano. Per poterne regolare la funzione motoria senza problemi, una parte del cervello ha dovuto assumere il ruolo di parte dominante. In questo contesto sarebbe risultato decisivo un dettaglio. La parte del nervo ricorrente, che controlla le corde vocali circonda l’aorta a sinistra: ecco perché misura circa dieci centimetri in più della parte destra. In questo modo, un impulso proveniente dall’emisfero cerebrale sinistro arriverebbe prima, accumulando un vantaggio difficilmente recuperabile. Alcuni ricercatori, tra cui l’antropologo neozelandese Michael Corballis, dell’Università di Auckland, ritengono invece che l’origine del linguaggio risiede nella gestualità della nostra specie, e portano avanti un modello che vede un vantaggio evolutivo connesso all’abbinamento di linguaggio e lateralità. La supremazia dell’emisfero sinistro rispetto al destro nelle funzioni motorie avrebbe quindi semplicemente dato un impulso alla localizzazione del linguaggio e della lateralità nell’emisfero sinistro, il lato del cervello dove le due funzioni possono combinarsi più facilmente l’una con l’altra.